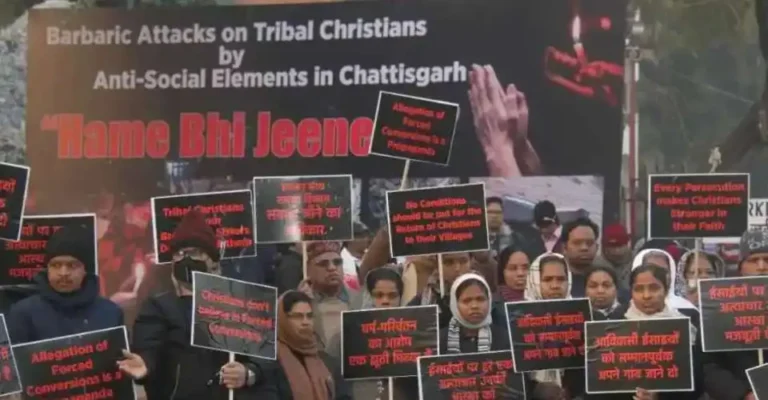L’Afghanistan fuori dal mondo

Di Enrico Campofreda, giornalista e scrittore, da Confronti
A quattro anni dalla presa di Kabul, il regime talebano consolida il potere tra isolamento internazionale, crisi umanitaria e repressione dei diritti civili, soprattutto delle donne. Mentre il mondo occidentale chiude le porte, i talebani tessono relazioni strategiche e partecipano a colloqui diplomatici. Intanto, migliaia di afghani fuggono o sopravvivono nella povertà, tra campi profughi e corridoi umanitari.
Hibatullah Akhundzada nell’unica, o quasi, immagine che circola sul suo conto con barba d’ordinanza e turbante bianco, a inizio settembre s’appresta a consolidare il quarto anno da “emiro”, ovvero guida suprema talebana. Ruolo da scrivere un po’ con la minuscola, niente a che vedere con la gerarchia vantata dagli sciiti iraniani. Eppure lui, sunnita, lo preserva accanto a quello della creazione del Secondo emirato afghano risorto il 15 agosto 2021. Quattro anni trascorsi e sembrano molti di più. Perché i media internazionali pronti in quell’infuocata estate a seguire ogni passo della dismissione del potere di Ashraf Ghani, premier inventato da Stati Uniti e Banca Mondiale, nel giro di qualche giorno dimenticarono Kabul e la sua gente, puntando gli obiettivi solo sulle truppe che mollavano la capitale, come aveva già fatto l’Armata Rossa (15 febbraio 1989), e in similitudine con la rotta statunitense da Saigon (30 aprile 1975).
SANZIONI E PROFUGHI
Uniche eccezioni gli scoop sui leader taliban che entravano a Palazzo, accomodati su poltrone vellutate e dorate, tra flash e puntuali dichiarazioni d’intenti e di programma rilasciate dall’uomo della comunicazione, da quel momento diventato celebre: Zabihullah Mujahid, attualmente viceministro della Cultura e dell’Informazione. Quasi subito partiva la “cortina di ferro”, informativa innanzitutto, perché dalla Casa Bianca si stabilivano i termini dell’isolamento e della punizione, tramite il blocco dei fondi nazionali, oltre 9 miliardi di dollari tuttora fermi in alcune banche americane ed europee; mentre l’Occidente, smarrito sul terreno militare e politico, si prendeva la rivincita sostenendo la bontà delle sanzioni. Giustificate anche dall’ottusa linea di taluni ministeri ripristinati, quello della Promozione della Virtù e della Prevenzione del Vizio che “niqabava” le poche donne mantenute in vista addirittura davanti alle telecamere d’una purgata Tv di Stato. Poi, mese dopo mese, cresceva lo stillicidio dei divieti per le donne: nessuna presenza fuori dall’abitazione senza l’accompagnatore (mahram o giù di lì: termine con il quale si indica ogni uomo con il quale una donna ha un legame – di sangue o di allattamento – che esclude il matrimonio), scuole proibite per le ragazze oltre i dieci anni, fino alla definitiva chiusura in casa senza contatti con l’istruzione e la società. Lo sport, la danza, la musica neanche a parlarne, tornavano tabù e continuano a esserlo…
Eccessi d’un ottuso deobandismo non solo religioso, ma politico e tribale che unisce claniche interpretazioni della Shari’a e del pashtunwali – un codice consuetudinario ed etico non scritto nonché uno stile di vita tradizionale che segue il popolo pashtun – su cui però, come vedremo, insistono differenze e diversità d’interessi fra boss del nuovo potere. Eppure anno per anno – nonostante il blocco dei fondi nazionali, oltre 9 miliardi di dollari tuttora fermi in alcune banche americane ed europee – si scopre che i mullah (“tutore”, “signore”) dell’Emirato così isolati non restano. Sia per i fraterni contatti coi gruppi talebani presenti sul e oltre confine pakistano, sia perché il blocco del mondo che non guarda a Occidente per i motivi più vari (affari, geopolitica, fedi, tradizioni e tant’altro) non si fa congelare dalla Diplomazia con la maiuscola. Del resto quest’ultima, di cui appunto europei e statunitensi si fanno vanto, ha in alcune figure e soprattutto strutture (le varie Intelligence) il “Cavallo di Troia” per dialoghi a tutto tondo.
Infatti la politica americana, che ha scelto di ritirare gli scarponi dal terreno afghano in virtù di particolari accordi coi vituperati turbanti, non ha del tutto abbandonato le basi aeree create.
Comunque l’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Unama) – istituita nel marzo 2002 con la risoluzione Onu 1401 – forse a parziale conforto della guerra dichiarata sei mesi prima dal quarantatreesimo presidente Usa, prosegue un’azione d’assistenza a una popolazione rimasta povera e assillata da una difficile sussistenza. Nel 2024 l’agenzia ha calcolato 23,7 milioni di afghani, e 3 milioni di bambini, bisognosi d’aiuto per la nutrizione quotidiana, una falla ingigantita proprio dai tagli economici internazionali e dalle più recenti contrizioni: dei 3 miliardi di dollari necessari erano giunti solo 650 milioni. Un castigo per i cittadini, non per gli apparati gestiti da taliban e accoliti.
FUGA DALL’EMIRATO
Per quello che s’è visto da almeno quattro decenni e che si continua a osservare, escludendo le emergenze di guerra, fame e malattie, una delle crisi che coinvolgono le famiglie locali con ricadute sulla comunità internazionale è la migrazione forzata. Tentativi d’espatrio fra i giovani che cercano una salvezza con la grande fuga verso un loro Occidente espanso che va dall’Iran, solitamente visto come primo approdo e terra di passaggio, alla Norvegia. Sebbene la “Fortezza Europa” abbia innalzato muri impercettibili fatti di doganieri armati e incanagliti da nuove regole non più accoglienti volute da molti Stati membri e dalla stessa istituzione di Bruxelles. Oppure più semplici rifugi, dopo percorsi relativamente brevi verso Islamabad o Peshawar, già negli anni Ottanta ciclopici campi profughi per milioni di fuggitivi dalle stragi dei signori della guerra. Lì generazioni di bambine e bambini afghani arrivavano, crescevano sotto le tende e le stelle, fra stenti e ristrettezze diventavano adulti e a loro volta genitori. Vite sigillate in un tempo sospeso. I pochi viaggi sicuri di profughi e rifugiati, tuttora in atto, ruotano attorno a iniziative di solidarietà, come i “corridoi umanitari” italiani progettati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche (Fcei) e dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione col ministero degli Esteri. A inizio luglio proprio quest’ultima ha condotto nel nostro Paese oltre un centinaio fra componenti familiari e singoli individui, tra loro quaranta minori. Si tratta comunque di profughi che, dalla fuga in Pakistan dopo l’arrivo dei taliban, stazionavano a Islamabad vivacchiando alla meno peggio.
Con l’Emirato non esistono protocolli in atto per simili uscite sia per l’assenza di rapporti ufficiali sia perché sicuramente i permessi verrebbero negati, la nazione non si priva dei suoi abitanti. Mentre degli allontanamenti successivi alla presa talebana di Kabul, compiuti anch’essi in aereo da amministratori e collaboratori dei governi Karzai e Ghani, che riparavano all’estero coi familiari, già al momento si sapeva o s’intuiva passassero per il benestare prima che dei turbanti dei “signori della guerra Nato”. Salire sui Boeing C-17 Globemaster in decollo o provare ad aggrapparsi alle ali precipitando tragicamente nel vuoto, come si vide fare a decine di disperati a ridosso di quel Ferragosto, segnava il confine fra la speranza di chi otteneva il benestare all’espatrio e l’angoscia suicida di chi lo vedeva negato.
Successivamente un errore informatico d’un militare britannico, che inviava una lista teoricamente top secret a un attivista per la ricollocazione di afghani, invischiati con le missioni Nato per appartenenza alle forze di Sicurezza o in qualità di semplici soldati dell’Afghan Defence Army – come rivela in questi giorni il quotidiano britannico The Times – da una parte metteva a repentaglio l’incolumità delle persone elencate, dall’altra confermava che le evacuazioni salvifiche erano programmate per queste categorie di cittadini. Oggi l’Unama gestisce altre precarietà, riguardanti i rimpatri che gli ultimi meno morbidi governi pakistani impongono all’Emirato. Quest’ultimo in parte tratta, poi nicchia oppure accetta e fa orecchie da mercante perché dovrebbe contribuire a sfamare un’infinità di bocche. «Quello che dovrebbe essere un momento positivo di ritorno a casa per le famiglie fuggite dai conflitti decenni addietro è segnato da esaurimento, traumi e profonda incertezza» ha affermato a metà luglio Roza Otunbayeva, portavoce del Segretario generale per l’Afghanistan in visita al valico frontaliero di Islam Qala, al confine con l’Iran, nella provincia occidentale di Herat. Ci sono già state altre grida di dolore come quella di Naseer Ahmad Andisha, rappresentante permanente dell’Afghanistan presso le Nazioni Unite a Ginevra, che esplicitamente parla della necessità d’un rinserimento del Paese nell’alveo della comunità internazionale. Un bel busillis. Andisha è un uomo d’apparato degli organismi internazionali. Nato nell’area di Kapisa fra le province del Panshir e Laghman, s’è formato fra l’Australia e il Texas, è stato ambasciatore, direttore presso la Divisione di Cooperazione economica nel lasso temporale delle “sperimentazioni di democratizzazione” del suo Paese, quando i chiacchierati esecutivi di Hamid Karzai [primo presidente eletto dell’Afghanistan in carica dal 7 dicembre 2004 al 29 settembre 2014] e Ashraf Ghani [Presidente della Repubblica islamica dell’Afghanistan dal 29 settembre 2014 al 15 agosto 2021, quando il suo governo venne rovesciato dai talebani] hanno inanellato mancanze, ruberie e poi inciuci con fondamentalisti del calibro di Mohammed Fahim, Karim Khalili, Gulbuddin Hekmatyar, Abdul Rashid Dostum fatti ministri e vicepresidenti. Forse anche per questo mister Andisha sa che in Afghanistan non c’è un “prima” e un “dopo”.
DIRITTI NEGATI
I fedeli che continuano a pregare in moschea, chi va al mercato a vendere e comprare povere cose, chi sente scorrere il tempo nelle casupole avvinghiate sulle colline d’una capitale soffocata e assetata (oltre 6 milioni gli abitanti e pozzi di pescaggio dell’acqua sempre più invasivi a fronte di scarse precipitazioni), intravede nel raggiunto biancore della propria chioma un abbandono costante, ultimamente accresciuto dal volere mondiale. Ma la mano tesa è contestata da altre realtà, radicate o effimere. Potenti o rappresentative solo sulla carta. Gli esempi vengono da parte di attori politici e della società civile, seppure molto diversi tra loro. Tra questi figura l’ex mujaheddin ed ex governatore della regione di Balkh, Atta Muhammad Noor, oggi esponente dell’opposizione attraverso il gruppo Jamiat-e Islami (“Associazione islamica”), tuttora presente nella Loya Jirga e già sodale di criminali di guerra come Dostum e Ahmad Shah Massud, attualmente riparato a Dubai. E poi un indebolito Movimento per la libertà delle donne, attivo nei primi mesi dopo il ritorno al potere dei talebani ma oggi segnato da repressioni e incarcerazioni. Entrambi i soggetti, sebbene con pesi molto diversi, hanno espresso la loro contrarietà al piano Mosaico di Unama, sostenendo che rischia di offrire all’Emirato un sollievo e una forma implicita di legittimazione, in linea con i colloqui in corso a Doha tra venticinque Paesi interessati a una normalizzazione dei rapporti con il regime talebano. Una mossa, affermano i detrattori, che non aiuta la popolazione civile, ma solo chi oggi detiene il potere a Kabul e nelle province. In aggiunta, quella parte di mondo che continua a voltare le spalle all’ipotesi d’apertura ai sodali di Akhundzada ricorda che costoro hanno tradito ogni buona intenzione in fatto di diritti civili e di genere, hanno accresciuto le discriminazioni verso le donne d’ogni età prospettando un oscuro ritorno alle pratiche del mullah Omar. Così alcune storiche attiviste provenienti dall’humus politico del Revolutionary Association Women of Afghanistan, come le ex parlamentari Malalai Joya e Belqis Roshan, per ragioni d’incolumità sono da tempo riparate all’estero. Le loro sorelle di lotta proseguono forme d’aggregazione con scuole e rifugi per donne, tutti clandestini e ad altissimo rischio di repressione. Dal canto suo la settantasettenne Mahmouba Seraj, fondatrice dell’Afghan Women’s Network e di recente in odore di candidatura al Nobel per la Pace, è convinta che coi taliban bisogna parlare. Per non restare in bilico e in sostanza fermi, come nella prima fase del cambio di regime, i partecipanti agli incontri di Doha (fra cui spiccano sauditi, emiratini, i padroni di casa qatarioti, ma anche le potenze regionali turca e pakistana) assieme ai funzionari Onu seguono un percorso a tappe, cadenzato punto su punto attorno a particolari tematiche, ad esempio narcotraffico e terrorismo.
ORTODOSSI E SCISSIONISTI
Nel 2020 s’era iniziato a discorrere di droghe, rispetto alle punte di produzione afghane d’oppio e metanfetamina in un mercato immenso che proprio in Occidente mostra una richiesta copiosissima. Nel 2022 la produzione risultava crollata del 90% per poi risalire in base agli interessi dei cartelli del narcotraffico che, a detta dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodoc), mette in relazione territori di produzione come l’Afghanistan e il Myanmar con aree di trasformazione (Messico), peraltro specializzata in ogni genere come accade con la coca e gli oppiacei sintetici, fentanyl e simili. Sarebbe interessante mettere a confronto il purismo moraleggiante dei turbanti, contrari (a parole) a sostenere il lucrosissimo mercato con le posizioni dei giganti del mondo capitalistico, Stati Uniti e la stessa Cina, solo teoricamente impegnati a stroncare tale commercio che invece galoppa nonostante i buoni propositi di tutti. Perciò sul narcotraffico i dialoghi vivono una schizofrenica scissione fra teoria e realtà.
Tendenza presente anche attorno alla questione del rifugio territoriale al terrorismo internazionale. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ispettorato speciale generale per la ricostruzione dell’Afghanistan (ennesima struttura creata nel 2002 attorno a politiche estere, militari e affaristiche statunitensi) in diverse province afghane covano covi del jihadismo mondiale da al-Qaeda allo Stato islamico del Khorasan (Isis-K). Leggendo il documento datato marzo 2025, indubbiamente dettagliato, viene da sorridere, poiché quando il Pentagono spingeva sulla Casa Bianca per eclissarsi da Kabul, portando a casa il grosso delle truppe lì impegnate e avviando la dismissione con la Resolute Support Mission – l’operazione della Nato in Afghanistan avviata nel 2015 dopo l’International Security Assistance Force e conclusa nel luglio 2021 con il ritiro delle truppe statunitensi e alleate – iniziava la battaglia interna tra “talebani ortodossi” e “talebani scissionisti” che avrebbero dato corpo alle milizie dell’Isis-K, che aggregava i primi elementi nella provincia di Nangarhar per poi espandersi a Sud e Ovest nell’Helmand e Farah. L’Isis-K cresceva in relazione al graduale tramonto del sedicente Daesh, sorto fra Siria e Iraq. E se per la cronaca dell’epoca, il triennio 2016-2019 è risultato il periodo più buio con stragi nelle moschee, nei mercati, fra la comunità hazara e indiscriminatamente per le strade della capitale quando brillavano auto e camion bomba, i due blocchi del jihadismo locale si combattevano a distanza per evidenziare chi controllava cosa da Kabul ai tradizionali territori della patria talebana, compresa Kandahar.
L’hanno spuntata gli “ortodossi”. Occupata la città-simbolo e il suo Palazzo la famiglia tradizionale talebana facente capo alla Shura di Quetta – il consiglio dei leader talebani, originariamente attivo da Quetta in Pakistan, con funzione consultiva per la guida suprema dell’Emirato islamico dell’Afghanistan – dove sono accasati turbanti duri e puri ma considerati pragmatici, come l’economista Abdul Ghani Baradar – co-fondatore dell’Emirato, di cui è presidente dal 15 agosto 2021 e poi dal 7 settembre 2021 anche Viceprimo ministro –, hanno ratificato il compromesso con la Rete Haqqani – l’organizzazione sunnita nata alla fine degli anni Settanta, inizialmente attiva nella resistenza antisovietica –, figli e parenti del capostipite Jalaluddin, un fondamentalista vicino alla Shura di Peshawar – il coordinamento delle fazioni mujaheddin afghane che, in esilio a Peshawar (Pakistan), fungevano da principale organo decisionale e rappresentanza della resistenza afghana negli anni Ottanta – e spesso in dissidio con le direttive centrali, comunque sempre indipendente per affari economici e azioni militari. Nel Secondo Emirato il suo erede Sirajuddin è diventato ministro dell’Interno, il fratello Khalil ministro dei Rifugiati (fino al 2024 quand’è morto in un attentato), il figlio minore e poeta Anas responsabile dell’Ufficio politico. Appartiene alla famiglia anche il sessantottenne sceicco Hakim, oggi ministro della Giustizia. I rabbiosi Haqqani, dunque, sembrano placati dal dominio, sicuramente istituzionalizzati controllano punti nodali del governo e possono guardare dall’alto anche l’erede del mullah padre-fondatore, il trentacinquenne Mohammad Yaqoob che guida il ministero della Difesa. Ora dibattere a Doha se il clan talebano più organico al deobandismo (la madrasa Darul Uloom Haqqania – conosciuta anche come “Università del jihad”, è stata fondata nel 1947 da Maulana Abdul Haq ed è uno dei più grandi seminari islamici del Pakistan, con una forte adesione al movimento Deobandi, una corrente religiosa islamica sunnita nata nel XIX secolo come reazione culturale e religiosa alla dominazione britannica in India – dove alcuni di loro hanno studiato e si sono formati, sugellando anche la propria denominazione) lasci spazi o addirittura copra il terrorismo jihadista sul territorio afghano, è domanda da trilioni di dollari. Peraltro i membri Haqqani negherebbero ogni evidenza che del resto appare fittizia. Alle trascorse taglie sulla cattura di Sirajuddin (10 milioni di biglietti verdi) da un anno il ministro oppone, e ostenta, visibilità estera. Se ne va negli Emirati Arabi, vede funzionari Onu e pure quegli statunitensi che gli pongono sulla testa il corposo riscatto senza che nulla accada. Incarna anch’egli quella geopolitica degli interessi che vince su quella dei buoni propositi. Del resto per incontrarsi in Qatar altri esponenti dell’Emirato (mullah Haq Whatiq, Muhammad Saqib) viaggiano, incrociano omologhi e dialogano. Sono il volto d’una normalizzazione strisciante. Mentre sulla vicenda di basi d’addestramento jihadista denunciate dall’Onu nelle province di Gazni, Zabul, oltreché in Nuristan, Kunar, Nangarhar, i corridoi d’infiltrazioni nelle incontrollabili Aree tribali federali – originariamente una regione autonoma tribale pakistana a forte impronta pashtun, poi assorbite nella provincia afghana del Khyber Pakhtunkhwa – e nel Waziristan hanno conosciuto per decenni un corposo scambio di visite. Il governo kabuliota vorrà tamponare quegli storici confini porosi? Forse. O invece no. Dipende dalle convenienze, da quel che accade a Islamabad. All’epoca del governo di Imran Khan (autunno 2021) che discorreva col leader pur incarcerato dei Tehreek-i Labbaik (il movimento politico-religioso di estrema Destra nato nel 2015), che assieme ai Tehreek-i Taliban e ai Lashkar-i Taiba (“L’esercito dei puri”, un’organizzazione islamista pakistana fondata alla fine degli anni Ottanta come ala militare di Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad, un gruppo islamista sunnita affiliato alla scuola Ahl-e-Hadith) sono i più sanguinari jihadisti pakistani benvoluti dagli Haqqani, uno scambio di “vedute” e favori con questi fratelli era possibile. Chi provava a squassare il neonato Emirato erano i ribelli del Khorasan, che ancora preoccupano i turbanti di Kabul. Bisognerà vedere chi i registi dell’instabilità occulta vorranno foraggiare e a chi la comunità internazionale vorrà tendere la mano.
[Fonte: Confronti; Foto: Confronti/Afghanistan Evacuation © U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen, Public domain, via Wikimedia Commons]