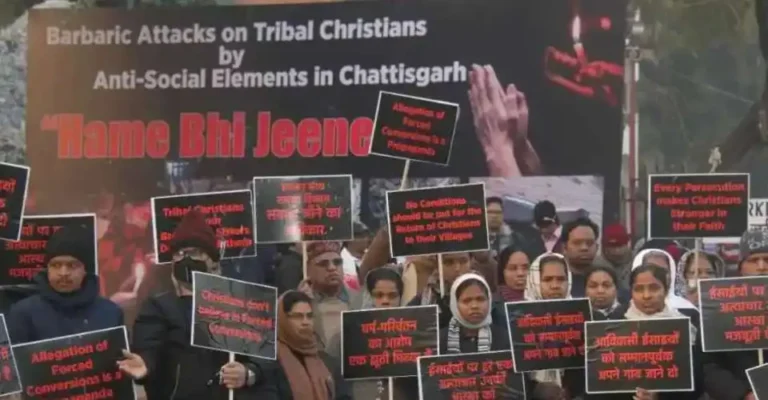Quattro anni di Emirato islamico d’Afghanistan: un bilancio

Il leader supremo si rafforza, così come l’Emirato, che incassa il riconoscimento formale di Mosca. Ma il consenso interno rimane circoscritto, anche a causa delle politiche discriminatorie verso le donne, che approfondiscono la gravissima crisi umanitaria. L’analisi di Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore freelance, per l’ISPI.
A quattro anni dal loro ritorno al potere, i Talebani consolidano l’Emirato islamico d’Afghanistan e il leader supremo orienta sempre più la direzione politica centralizzando il potere, con una pulsione autoritaria tradotta anche in persecuzione di genere, sanzionata dai recenti mandati di arresto della Corte penale internazionale. Il governo di fatto incassa il primo riconoscimento formale da parte della Federazione russa, insieme alla normalizzazione delle relazioni con i Paesi della regione. Un processo contestuale all’aumento della distanza con la comunità euro-atlantica, che approfondisce il disimpegno diplomatico e finanziario, frustrata dall’incapacità del fronte pragmatico dei Talebani di ottenere revisioni delle leggi più oppressive. Gli Stati Uniti ridisegnano l’intero ecosistema umanitario, ponendo fine agli aiuti finanziari, con conseguenze deleterie per la popolazione che sconta una gravissima crisi umanitaria, aggravata dai deficit di un sistema economico con segnali di ripresa a livello macroeconomico, ma incapace di redistribuire ricchezza e ridurre le disuguaglianze, gravato dal blocco delle riserve della Banca centrale, dalla mancanza di liquidità e dall’isolamento del sistema bancario.
L’Occidente si “ritira”, ma l’Emirato ottiene il primo riconoscimento formale
Sul fronte diplomatico, il 2025 è segnato dal riconoscimento dell’Emirato da parte di Mosca, dalla normalizzazione dei rapporti con i Paesi della regione e dall’accentuarsi della distanza con la comunità euro-atlantica, su cui pesa anche la decisione dell’amministrazione Trump di porre fine agli aiuti umanitari.
Una pagina sembra ormai voltata: i diplomatici occidentali sono rimasti a lungo in attesa che venissero mantenute le promesse dei pragmatici, quella coalizione piuttosto eterodossa di Talebani divisi da interessi e orientamenti ma uniti dalla volontà di ripristinare rapporti ragionevoli con l’Occidente e drenarne nuove risorse. A lungo hanno continuato a garantire che le scuole secondarie per le ragazze – chiuse da più di 1400 giorni – sarebbero state riaperte, che le politiche segregazioniste, attuate in modo sistematico e intenzionale, sarebbero state revocate o riformulate, che la torsione oltranzista, autoritaria e repressiva sarebbe stata attenuata. Nulla di tutto questo è avvenuto. I pragmatici hanno così perso credibilità, marginalizzati dall’emiro, Haibatullah Akhundzdada, che ha usato, oltre alla leva finanziaria, i decreti più radicali e discriminatori verso le donne per compromettere le aperture dei pragmatici con l’Occidente e riconquistare piena centralità di governo.
I rapporti con l’Occidente continueranno a rimanere in stallo, se non peggioreranno. Oggi sono rarissimi i diplomatici europei che si aspettano novità rilevanti nel breve periodo nei rapporti con l’Emirato. La percezione, semmai, è opposta, tanto che – scrive Antonio Giustozzi nel suo contributo – alcuni Paesi stanno ridimensionando la propria presenza diplomatica a Doha, la capitale del Qatar dove dal collasso della Repubblica islamica nell’estate 2021 anno trovato sede molte rappresentanze diplomatiche occidentali.
L’Onu ribadisce gli obiettivi di fondo: un Afghanistan in pace con se stesso e con i suoi vicini, pienamente reintegrato nella comunità internazionale e che adempia ai suoi obblighi internazionali. Per ottenerlo, punta a “approccio globale”, comprensivo, che passa attraverso gruppi di lavoro tecnici su questioni chiave, come il settore economico privato e il narcotraffico. L’idea è che, in un quadro multilaterale strutturato, il dialogo, la cooperazione e la ricostruzione progressiva della fiducia possano accorciare le distanze e reintegrare il Paese nel consesso internazionale. Obiettivi e metodo sono stati descritti dalla rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan e responsabile di Unama, la missione Onu a Kabul, Roza Otunbayeva, il 23 giugno scorso, quando ha informato il Consiglio di sicurezza sullo stato dell’impegno con i Talebani, nel corso della sessione sulla situazione in Afghanistan. Otunbayeva ha riconosciuto le preoccupazioni sull’efficacia della strategia adottata finora, ma ha anche osservato che “il Paese sarebbe in una situazione molto peggiore senza la presenza e l’assistenza della comunità internazionale”. Il cui impegno fornisce almeno “un elemento di protezione e prevenzione”. La stessa Onu, però, sconta ancora le conseguenze della gestione a tratti maldestra degli incontri di Doha del giugno/luglio 2024. Allora, la scelta di escludere dagli incontri ufficiali con i Talebani i rappresentanti della società civile ha portato a galla e cristallizzato la spaccatura tra l’approccio pragmatico dei Paesi regionali e quella ispirata a principi e valori dell’Occidente. A distanza di un anno, al tentativo di trovare una posizione comune, orchestrata, si va sempre più sostituendo il dialogo bilaterale, spesso informale, a volte opaco con le autorità di fatto. Come ha fatto il governo tedesco il quale, pur non riconoscendo l’Emirato né avendo scambi diplomatici ufficiali, è riuscito ad assicurarsi che Kabul accettasse il rimpatrio di migranti afghani con un volo apposito da Lipsia, in cambio, pare, dell’accettazione di funzionari dell’Emirato nelle sedi diplomatiche afghane in Germania.
Se la comunità euro-atlantica, frustrata dagli scarsi risultati ottenuti nel confrontarsi con un regime a più facce ma apparentemente inamovibile nelle politiche di persecuzione di genere, tira i remi diplomatici in barca, i Paesi della regione vanno sempre più normalizzando i rapporti. Sono “almeno 17 i Paesi che hanno ambasciate nell’Afghanistan governato dai Talebani, mentre diplomatici nominati dai Talebani rappresentano il Paese nella maggior parte delle capitali asiatiche, anche se il più delle volte a livello di incaricati d’affari”, ricorda l’International Crisis Group. La normalizzazione delle relazioni diplomatiche con i Talebani dopo la presa di potere nel 2021 è avvenuta gradualmente, ma prosegue. Esemplare da questo punto di vista la decisione del governo russo di riconoscere formalmente l’Emirato. Si tratta del primo Paese al mondo a farlo, e non rimarrà l’unico.
Il riconoscimento da parte della Federazione russa
Da giovedì 3 luglio 2025 sul balcone di un edificio di via Povarskaya 42, a Mosca, non sventola più il tricolore della Repubblica islamica, il governo afghano collassato nell’agosto 2021, ma una bandiera bianca su cui campeggia una scritta nera, la shahada, la professione di fede islamica. È la bandiera dell’Emirato islamico d’Afghanistan, e quello della Federazione russa è il primo governo al mondo a riconoscere ufficialmente il governo dei Talebani. Secondo il comunicato del ministero degli Esteri russo, “l’atto di riconoscimento ufficiale del governo dell’Emirato islamico dell’Afghanistan darà impulso allo sviluppo di una produttiva cooperazione bilaterale tra i nostri Paesi in vari campi”. Mentre per Amir Khan Muttaqi, ministro di fatto degli Esteri afghano, non si tratta che di un inizio: “Apprezziamo questo passo coraggioso compiuto dalla Russia e, a Dio piacendo, servirà da esempio anche per gli altri”, ha dichiarato sui social.
Il riconoscimento dell’Emirato è parte di un lunghissimo processo politico e diplomatico, non certo una svolta. Nell’avvicinamento, in questi anni un ruolo chiave l’ha giocato Zamir Kabulov, l’inviato speciale del presidente Putin. Alle spalle una lunghissima esperienza nel Paese, da ricondurre ai tempi dell’occupazione sovietica, quando era solo un diplomatico dell’ambasciata sovietica a Kabul, Kabulov è stato tra quelli che più hanno insistito con Putin sulla necessità di aprire ai Talebani, anche contro le raccomandazioni dei servizi. E non da oggi. È anche grazie a lui se Mosca ha superato quella che lo studioso russo Vladimir Boyko ha definito come una vera e propria “sindrome afghana”, figlia dell’esito fallimentare dell’occupazione sovietica, cominciata nel dicembre del 1979 e conclusa nel febbraio del 1989. La sindrome era ancora evidente ai tempi del primo Emirato. Ma con il rovesciamento del primo governo talebano, nel 2001, e la successiva presenza della Nato, le cose sono cambiate. Mosca assume una posizione attendista, per poi cominciare a tessere le relazioni con i Talebani, all’epoca all’opposizione armata del governo di Kabul. In particolare dal 2014, con l’inizio del lungo disimpegno della Nato. Nel 2016 Kabulov dà la linea in un’intervista all’agenzia turca Anadolu: “la maggioranza dei Talebani, inclusa la leadership”, non è che “una forza locale”, “che ha abbandonato l’idea del jihad globale”. Dal ministero degli Esteri di Mosca fanno sapere che serve “un approccio flessibile per rimuovere alcune figure dalla lista delle sanzioni” Onu. Già cinque anni prima del loro ritorno al potere, dunque, i Talebani sono interlocutori legittimi, anche come alleati contro i jihadisti globalisti (Stato islamico, al-Qaeda e affini), ritenuti una minaccia seria alla sicurezza della frontiera più esterna dell’impero russo; e come sponda per impedire l’ingresso nella regione di oppio e derivati. Ragioni che Mosca continua a considerare cruciali, così come molti altri Paesi della regione. Non è un caso che di recente lo stesso Kabulov abbia invocato l’invio di aiuti militari ai Talebani in funzione anti-terrorismo.
Il ruolo di Kabul nella lotta contro la minaccia della branca locale dello Stato islamico, la Provincia del Khorasan (Iskp or Isis-K), così come l’ambizione “del governo di fatto di riuscire a collegare l’Asia centrale all’Asia meridionale attraverso vari megaprogetti nel settore dell’elettricità, del commercio, degli oleodotti e della ferrovia trans-afghana, hanno svolto un ruolo fondamentale nell’avvicinare l’Afghanistan e i Paesi vicini”, è stato ricordato di recente da Ibraheem Bahiss dell’International Crisis Group, secondo cui “gli Stati dell’Asia meridionale e centrale probabilmente approfondiranno il loro impegno con i talebani e seguiranno l’esempio della Russia nell’instaurare formalmente relazioni diplomatiche”. Inclusa la Cina, il primo Paese ad aver formalmente accreditato un diplomatico talebano come ambasciatore nel dicembre 2023 e che, per le autorità di fatto afghane, è un partner economico fondamentale.
Nessuna vera opposizione
L’abilità nel “sigillare” diplomaticamente tutti i confini, con accordi, incontri, scambi commerciali che prevengano anche eventuali falle attraverso cui far entrare nel Paese armi per l’opposizione, rende l’ipotesi di una resistenza armata del tutto inverosimile, per ora. L’opposizione armata è del tutto divisa, con scarse risorse finanziarie e pressoché nessuna sponda regionale e politica, visto che perfino il Tagikistan sembra aver trovato un compromesso con le autorità di fatto afghane.
La branca locale dello Stato islamico nei primi due anni dell’Emirato ha cercato seriamente di minarne le fondamenta attraverso azioni militari, oltre che con un’attenta campagna di “diffamazione” sui canali della propaganda jihadista. Ma entrambe le operazioni sono state inutili: contrariamente alle intenzioni dell’Iskp, l’Emirato appare sempre più, agli occhi dell’ecosistema jihadista, un vero governo islamico, alieno ai compromessi con l’Occidente corrotto, capace di “tenere la rotta”, nonostante le pressioni esterne. Militarmente Iskp ha scontato invece la pressione dei Talebani, pur rimanendo un attore capace di impensierire le cancellerie straniere, a causa della sua capacità di orchestrare ed eseguire attentati terroristici. Secondo il rapporto pubblicato a febbraio dal team delle Nazioni Unite incaricato di monitorare le sanzioni, l’Iskp rappresenta ancora “la più grande minaccia terroristica extraregionale” e il pericolo più grave per i Talebani, le minoranze etniche e religiose, le Nazioni Unite, i cittadini stranieri e i diplomatici in Afghanistan.
La persecuzione di genere
A rafforzare i legami tra i Paesi della regione e l’Emirato è anche la recente decisione dei giudici della Corte penale internazionale, che martedì 8 luglio hanno emesso mandati di arresto per Haibatullah Akhundzada, il leader supremo dei Talebani, e per Abdul Hakim Haqqani, a capo della Corte Suprema. Secondo i giudici della Corte, ci sono sufficienti elementi per ritenere che “abbiano commesso – ordinando, inducendo o sollecitando – il crimine contro l’umanità di persecuzione”. Persecuzione “per motivi di genere, contro ragazze, donne e altre persone non conformi alla politica dei Talebani in materia di genere e identità”. Si tratta di “atti di violenza diretta, ma anche forme di danno sistemico e istituzionalizzato, compresa l’imposizione di norme sociali discriminatorie”. I mandati per l’Amir al muminin, la Guida dei fedeli, che da Kandahar detta la linea oltranzista e autarchica dei Talebani, e per Abdul Hakim Haqqani, a cui si deve uno dei pochi libri meditati sulle istituzioni dell’Emirato, rovinano solo parzialmente le celebrazioni con cui i Talebani hanno incassato il riconoscimento da parte di Mosca e con cui in queste ore festeggiano i quattro anni di potere.
Per il portavoce dell’Emirato, infatti, i Talebani non riconoscono alcuna istituzione denominata Corte penale internazionale, “né abbiamo obblighi nei suoi confronti”, mentre la decisione di “attribuire alle leggi della Sharia islamica il carattere disumano e oppressivo” dimostra solo “aperta ostilità e odio verso la sacra religione dell’Islam”. Di segno opposto le reazioni delle organizzazioni per i diritti umani, per le quali i mandati interrompono almeno simbolicamente un ciclo di impunità durato troppo lungo. Per Richard Bennett, il relatore speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan a cui le autorità di fatto hanno infine negato l’accesso nel Paese, la decisione è storica. E in linea con i risultati del suo ultimo rapporto, presentato l’11 giugno all’Onu e dedicato all’accesso alla giustizia per donne e ragazze: “i Talebani stanno strumentalizzando il settore legale e della giustizia in Afghanistan come parte dei loro sforzi per consolidare il sistema istituzionalizzato di oppressione, persecuzione e dominio di genere”, ha sostenuto in quell’occasione Bennett.
Secondo l’associazione Rawadari, che svolge attività di monitoraggio sulla negazione dei diritti in Afghanistan, e di cui fa parte anche l’ex responsabile dell’Afghanistan Independent Human Rights Commission, Shaharzad Akbar, l’azione della Corte penale internazionale “rappresenta un passo importante verso l’obbligo di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini commessi in questo Paese e potrebbe aprire la strada a procedimenti giudiziari in altri casi relativi a crimini internazionali”. Rawadari legge la decisione della Corte come una risposta indiretta al recente annuncio da parte di Mosca: “riconoscere i talebani non solo impedisce la giustizia, ma consente anche il proseguimento e il sostegno a diffuse violazioni dei diritti umani”. Ma l’associazione enfatizza anche “la necessità di affrontare tutti i casi relativi a crimini internazionali in questo Paese”. E, insieme ad altre organizzazioni afghane – Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (Ahrd), Organization for Policy Research and Development Studies (Drops) e Human Rights Defenders Plus (Hrd+) – pochi giorni fa ha annunciato il lancio di una sessione per le donne afghane al Tribunale Permanente dei Popoli (Tpp), un’iniziativa volta ad arginare l’impunità delle persecuzioni di genere in Afghanistan. “Con il lancio di questa sessione, la società civile afghana e i gruppi per i diritti delle donne intendono creare un canale per accertare le responsabilità dei Talebani per i loro crimini e chiedere giustizia, lanciare l’allarme sulla normalizzazione dell’oppressione delle donne da parte dei Talebani e dare a donne e ragazze la possibilità di essere ascoltate in tutto il mondo”, si legge sul sito del Tribunale Permanente dei Popoli, il tribunale d’opinione internazionale fondato da Lelio Basso che si occupa di casi di gravi violazioni dei diritti umani, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidi.
I mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale sono stati accolti con favore dalla società civile, dalla diaspora afghana, da molte organizzazioni per i diritti umani, per il loro immenso valore simbolico e pratico e per il messaggio chiaro che portano con sé: “la difficile situazione delle donne afghane e le atrocità commesse dai talebani non sono state ignorate”. Molti Paesi regionali non ne terranno conto, ma per altri potrebbero costituire un disincentivo a ipotetiche normalizzazioni dei rapporti. All’interno dell’Afghanistan gli effetti sono più controversi, perché i mandati rafforzano la percezione dei Talebani di essere ancora in guerra con l’Occidente, conducendo inoltre a un ulteriore inasprimento della repressione. Subito dopo l’annuncio della Corte penale, si sono intensificate le attività dei muthasibin, i funzionari del ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio che hanno il compito di vigilare sull’applicazione delle leggi, sulla moralità, e – come ci ha spiega lo scorso ottobre a Kabul il portavoce, Saif-ul-Islam Khyber, di ammonire dove necessario, di consigliare. Con metodi sempre più muscolari, secondo molte testimonianze. Attività di controllo sociale che si sommano a quelle repressive degli organi di sicurezza, a cui vengono attribuite molte negazioni di diritti.
L’ultimo rapporto sulla situazione dei diritti umani di Unama, la missione Onu a Kabul, è stato pubblicato pochi giorni fa. Riguarda il periodo aprile-giugno 2025, e include una novità significativa, rispetto ai rapporti precedenti, tutti contrassegnati da episodi e tendenze che descrivono continue negazioni dei diritti nel Paese: nel mese di maggio alcune dipendenti afghane di sesso femminile delle Nazioni Unite sono state oggetto di minacce di morte dirette. Il portavoce del Ministero dell’Interno, Abdul Mateen Qani, ha però negato qualsiasi minaccia, aggiungendo che “il ministero dispone di un dipartimento indipendente dedicato a questo, e abbiamo un piano strategico per la protezione e la sicurezza, quindi non c’è alcuna minaccia per loro in nessuna zona”.
La crisi umanitaria
Attività ed efficacia dell’ecosistema umanitario sono state fortemente compromesse dalla decisione dell’amministrazione Trump di interrompere pressoché tutte gli aiuti finanziari, nonostante i bisogni della popolazione siano ancora drammaticamente insoddisfatti, con almeno metà della popolazione che necessita di assistenza di base. Nel rapporto di giugno del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Afghanistan, viene ricordato che la diminuzione dei finanziamenti stranieri per l’aiuto umanitario ha “aggravato la situazione economica disastrosa di milioni di afghani gli afghani”, afflitti “da sfide multiple” tra cui la povertà diffusa, l’accesso limitato ai servizi di base, i disastri naturali e il governo oppressivo dei Talebani. Per l’anno fiscale in corso, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Ocha, ha richiesto 2,42 miliardi di dollari ai donatori per sostenere i servizi umanitari salvavita a favore di 22,9 milioni di persone in Afghanistan. Gli Stati Uniti hanno però cessato gli aiuti umanitari per l’Afghanistan, con l’ordine esecutivo numero 14169 del presidente Trump, “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”. Una decisione con profondissime ripercussioni sulla popolazione afghana, come descritto da Kate Clark dell’Afghanistan Analysts Network.
Nel 2024, gli Stati Uniti sono stati infatti il principale donatore dello Humanitarian Response Plan, il Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, contribuendo per il 45% del finanziamento totale, con un contributo di 736,6 milioni di dollari. Anche in chiave storica, hanno giocato un ruolo centrale. Secondo Ocha, sono stati infatti il principale donatore per la risposta umanitaria in Afghanistan dal 2013, fondamentali anche nelle risposte di emergenza, tra cui la prevenzione della carestia nel 2021 e nel 2022 attraverso un sostegno “robusto” alla sicurezza alimentare e agli interventi nutrizionali. La perdita del contributo di un donatore così importante, viene ricordato nell’ultimo rapporto Sigar (lo Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction del Congresso Usa), ha costretto Ocha a ridurre i propri sforzi, rivolti ora non più a 22,9 milioni di persone, ma a 12,5 milioni tra quelle che secondo l’organizzazione si trovano in condizioni di grave necessità, così come a ridurre la richiesta di finanziamento da 2,42 miliardi di dollari a 1,62.
L’amministrazione Trump mette fine agli aiuti finanziari
Le conseguenze della decisione dell’amministrazione Trump andranno valutate nel medio-lungo periodo, ma hanno cominciato già dispiegarsi e le principali agenzie delle Nazioni Unite avvertono del pericolo: dopo l’annuncio da parte di Washington, il World Food Programme ha dichiarato che la cessazione dei finanziamenti “potrebbe equivalere a una condanna a morte per milioni di persone che soffrono di fame estrema e denutrizione”. A giugno, l’agenzia ha dovuto interrompere la fornitura di sostegno nutrizionale mensile a circa 100.000 bambini afghani e 150.000 donne afghane in gravidanza e in allattamento. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver dovuto chiudere 422 strutture sanitarie da quando gli Stati Uniti hanno ritirato il proprio sostegno finanziario, con ripercussioni su circa 3 milioni di persone in 30 province. A maggio, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) ha dichiarato invece di non poter più sostenere 500 delle 900 cliniche sanitarie sostenute prima del taglio dei finanziamenti.
Le crisi multiple che gravano sul Paese sono ulteriormente aggravate dai flussi migratori di ritorno, in particolare da Iran e Pakistan, i due Paesi che maggiormente hanno accolto, nel corso dei decenni, le spinte migratorie dall’Afghanistan. E dai quali, negli ultimi mesi, sono stati intensificati rimpatri, respingimenti, deportazioni, anche forzate. Di recente, l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite ha avvertito che il Paese non è in grado di assorbire gli 1,9 milioni di afghani costretti a tornare dall’Iran e dal Pakistan solo nel 2025. Anche il rappresentante dell’Unhcr a Kabul ha invitato la comunità internazionale a rispondere con aiuti di emergenza e sostegno a lungo termine, sottolineando che “il calo del sostegno internazionale sta aggravando le crisi complesse e sovrapposte in Afghanistan”. Senza finanziamenti immediati e consistenti, per l’Unhcr – che il 4 luglio ha reso pubblica una richiesta di finanziamenti aggiuntivi – la portata dei rimpatri potrebbe destabilizzare la situazione già fragile in Afghanistan.
La nuova posizione del governo degli Stati Uniti – che ha trainato l’intervento militare della Nato e, poi, quello umanitario della comunità euro-atlantica anche dopo l’agosto 2021 – è però netta. Ed è stata chiaramente espressa il 7 luglio 2025, quando gli Usa sono stati uno dei due soli Stati membri delle Nazioni Unite a votare contro una risoluzione che chiedeva un aumento degli aiuti umanitari all’Afghanistan. La risoluzione, approvata con 116 voti a favore, due contrari e 12 astensioni, è stato così commentata dal Dipartimento di Stato: “È posizione degli Stati Uniti che non possiamo continuare a sostenere i talebani e contemporaneamente esigere che rispettino i loro impegni internazionali e gli obblighi internazionali dell’Afghanistan”.
Si tratta di una decisione che aggrava una situazione già compromessa da decisioni precedenti. Come ricorda l’ultimo comunicato di United Against Inhumanity (Uai), movimento globale di gruppi e individui con una lunga esperienza professionale nelle agenzie dell’Onu e in Afghanistan, “i membri della Nato che hanno combattuto in Afghanistan hanno tagliato tutti i finanziamenti per lo sviluppo nel 2021”. Più di recente, “hanno bruscamente ridotto il sostegno finanziario ai programmi umanitari, nonostante l’aumento delle necessità umanitarie quest’anno”. Oltre agli Stati Uniti, anche “il Regno Unito, la Germania, l’Olanda, la Svezia e il Belgio hanno tagliato i loro finanziamenti umanitari”, nonostante la Commissione europea abbia recentemente assicurato 161 milioni di euro per la popolazione afghana, nel Paese e nella regione. Secondo Uai, tali politiche di riduzione degli aiuti dimostrano incoerenza: “la retorica sostenuta da vari governi sull’importanza di rispettare i diritti umani delle donne e delle ragazze afghane ignora al contempo che le loro politiche hanno effetti deleteri, soprattutto per le donne che sono ulteriormente emarginate e svantaggiate dalla povertà”.
L’economia, infatti, arranca: l’ultimo rapporto della Banca mondiale registra segnali di ripresa parziale e graduale, stimando nel 2024 una crescita economica del Prodotto interno lordo intorno al 2,5%, ma la bilancia commerciale rimane squilibrata, rendendo il Paese dipendente, i settori produttivi sono limitati, la ricchezza è tutt’altro che distribuita. Rispetto al passato, la contrazione complessiva dell’economia rimane significativa, mentre sono venute meno le ingenti risorse esterne che coprivano gran parte della spesa pubblica al tempo della Repubblica islamica, grazie agli aiuti allo sviluppo, quasi del tutto congelati. L’economia si regge perlopiù sugli accordi per le estrazioni minerarie e su un sistema di tassazione spinto fino al limite. I recenti tagli su personale e salari di molti ministeri, inclusi, pare, quelli della Difesa e degli Interni, testimonia una razionalizzazione delle risorse ma anche una loro insufficienza.
La povertà continua ad affliggere la maggior parte della popolazione, con effetti sulla dieta giornaliera e sull’accesso a cure e salute. È approfondita dall’isolamento del sistema bancario internazionale e dal congelamento all’estero delle riserve della Banca centrale afghana, Da Afghanistan Bank (Dab), come ricorda anche l’ultimo rapporto Sigar, secondo cui l’Afghanistan “soffre di una crisi di liquidità dovuta al suo isolamento dal settore bancario internazionale e all’incapacità della sua banca centrale, la Da Afghanistan Bank (Dab), di stampare nuove banconote afghane o sostituire quelle esistenti”. Secondo United Against Inhumanity, “l’unica risposta sostenibile è lo sviluppo di un’economia funzionante. Ciò evidenzia l’ovvia e urgente necessità di ricapitalizzare DAB”, anche in più fasi, e con il monitoraggio di attori terzi, internazionali, che verifichino il rispetto delle norme di antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
I nodi irrisolti
Oltre a quello economico, rimane irrisolto anche il nodo dell’architettura istituzionale dell’Emirato. Una questione solo apparentemente secondaria, perché ne dipende la distribuzione del potere e dunque l’assestamento o meno delle dinamiche interne conflittuali, tanto più potenzialmente deleterie per il governo dei Talebani tanto meno viene definita la struttura statuale e le relative divisioni di compiti, mandati, responsabilità, autorità.
Finora le dinamiche conflittuali sono state assorbite, anche grazie alla capacità dell’emiro di riportare all’ordine quanti hanno tentato di ostacolarne l’affermazione, limitarne il potere o delegittimarne le decisioni, ma l’incertezza istituzionale rimane un vulnus dell’Emirato. Così come la tendenza autoritario-repressiva interna: anche qui, per ora non ci sono le condizioni per una ribellione della popolazione, schiacciata dalla crisi umanitaria e dal timore degli apparati di intelligence del governo. Ma la frustrazione e l’insofferenza per le politiche discriminatorie verso le donne – abbiamo potuto constatare nel nostro ultimo viaggio nel Paese, a ottobre 2024 – cresce giorno dopo giorno. E il consenso dei Talebani rimane sostanzialmente limitato, parziale. La storia del Paese ci dice però che, da solo, il monopolio della forza e della violenza non assicura la stabilità delle istituzioni.
[Fonte e Foto: ISPI]